Demenza, il premio "Erik Stalberg" all'Italia per i passi avanti nella ricerca. Ecco quali
16 Maggio 2023 - 11:42Il professor Paolo Maria Rossini, Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Riabilitative dell'IRCCS San Raffaele, è stato l'unico italiano a ricevere il prestigioso premio “Erik Stalberg” per l'importanza delle ricerche sulla demenza. Nella nostra intervista racconta le nuove frontiere raggiunte
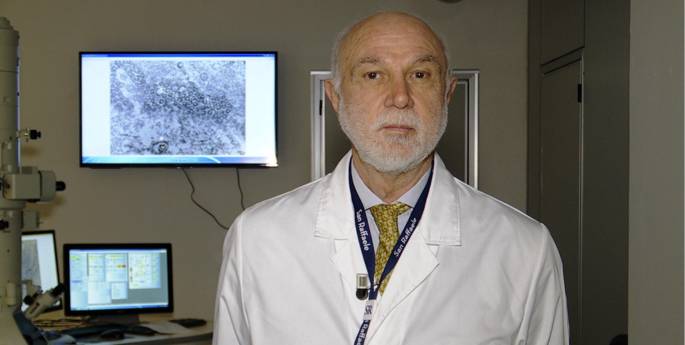
Un riconoscimento molto speciale è andato ad un'eccellenza della nostra medicina, il professor Paolo Maria Rossini, Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Riabilitative dell'IRCCS San Raffaele. Si tratta del premio “Erik Stalberg” per: "L’importante contributo nel campo della neurofisiologia clinica e per l’alto livello della produzione scientifica in molti ambiti delle neuroscienze ed in particolare delle malattie neurodegenerative e delle demenze". In questa motivazione non ci sono soltanto anni di lavoro, ma grande speranza per i malati di demenza e tutta quella serie di patologie neurodegenerative che al momento, non danno una speranza per il futuro, ma solo per i sintomi connessi. Grazie al lavoro del professore, ma anche di tutte le strutture e le competenze che in concerto hanno lavorato per raggiungere risultati, ci sono novità importanti in questo campo, che il premio ha sottolineato e portato alla luce, e che il professore stesso racconta nella nostra intervista.
Professore cosa ha rappresentato questo premio per lei?
"È sicuramente un bel riconoscimento personale, ma anche per tutti coloro che stanno svolgendo questa attività di ricerca e sperimentazione in Italia da decenni. Non è un caso che tra i tre premiati l'unico italiano sia stato io, (insieme al professore, tra i Top Scientists del mondo per la classifica stilata dall’Università di Stanford e pubblicata sulla rivista PlosBiology, sono stati premiati i Proff.ri Luis Garcia-Larrea dell’Università di Lione e Walter Paulus dell’Università di Dusseldorf, ndr). Mi occupo, ormai dalla fine del secolo precedente, di questa orribile malattia che fino a 50 anni fa era ritenuta non dico rara, ma abbastanza sporadica, e che al contrario ora è esplosa come una specie di epidemia".
Qual' è il motivo di questa crescita esponenziale negli anni?
"Principalmente sono due, anche se entrambi non allarmanti. Da una parte perché la gente invecchia di più dispetto al passato. Attualmente le persone sopra i 65 anni, sono un quarto della popolazione italiana, solo 50 anni fa erano il 5 per cento, e questa è una malattia che, anche se comincia molto prima, si esprime in età avanzata. Questo perché il nostro cervello, ha un sistema di resistenza che non permette di vedere i sintomi, anche se la patologia sta già lavorando. La seconda ragione è che ora si fa diagnosi molto più precisa rispetto a prima. Una volta si usavano termini come 'demenza senile', 'aterosclerosi', definizioni un po' generiche, che stavano ad indicare che un anziano non aveva più capacità intellettive, cosa totalmente falsa perché il nostro cervello è strutturato in maniera da mantenere una sua adeguatezza fino ad oltre i 100 anni. Dimostrazione ne è stata, la compianta professoressa Rita Levi Montalcini che a 100 anni ancora ragionava benissimo, e sapeva mettere i puntini sulle 'i' quando era necessario. Quindi facendo rispetto a prima più diagnosi, c'è potenzialmente tanta popolazione a rischio. Parliamo di tutti gli over 55".
Quali sono questi principali fattori di rischio?
"Li abbiamo studiati per anni e ce ne sono tanti. Sicuramente di tipo genetico, con famiglie molto più colpite, attraverso generazioni, rispetto ad altre che, pur invecchiando, non sembrano risentire di questo problema. Ci sono poi fattori di rischio di tipo medico, se ad esempio qualcuno è un diabetico mal controllato, un iperteso mal controllato, o cardiopatico. Al contrario abbiamo i 'fattori protettivi' che abbiamo imparato a conoscere solo da poco e che risultano fondamentali. Una sorta di bilancia, in cui da una parte ci sono i fattori di rischio e dall'altra quelli protettivi. Per fare un esempio, la stessa cosa succede nei tumori: tutti abbiamo cellule tumorali che girano nel nostro corpo e vengono rese innocue dal nostro sistema di difesa. Quando avviene uno sbilanciamento tra cellule malate e cellule di difesa, a favore di quelle malate, il tumore si esprime. Nelle malattie neurodegenerative accade la stessa cosa, quando i fattori di rischio superano la capacità di quelli di protezione, la malattia comincia ad esprimersi".
Come avviene lo sbilanciamento di questi fattori?
"Dico sempre che abbiamo un solo cervello, un organo che ha scarsamente capacità di riprodurre cellule. Non è così vivace come il fegato, le ossa o i muscoli, per cui dobbiamo trattarlo con cura. Per questo è importante condurre una vita che preveda sempre esercizio fisico e attività cognitive, perché facendolo lavorare e stimolandolo, si crea una specie di dote a cui attingere quando, a causa dell'invecchiamento, le cellule cominciano a morire. Per questo dicevo che i sintomi non si vedono, perché il cervello ha capacità di resilienza anche se non illimitata, costituita in parte geneticamente. Noi però possiamo rinforzarla e proteggerla con uno stile di vita adeguato, evitanto ad esempio traumi. Il fatto di indossare sempre il casco quando si va in motorino, è un investimento per il futuro, perché se si prende una botta violenta quando si hanno 20 anni, si perdono milioni di neuroni che non ci saranno più dopo i 50/60 anni. Proteggere e mantenere il cervello attivo per tutta la vita, migliora in qualche modo la resilienza, a quello che noi definiamo l''invecchiamento patologico del cervello', perché quello fisiologico di per sè non è una malattia, ma fa parte del normale deterioramente dovuto all'età".
Quali passi avanti sono stati fatti dalla medicina e dalla ricerca in questo ambito?
"Lo studio del processo di neurodegenerazione nella demenza è molto complesso, è una delle malattie più difficili da comprendere perché lavora nel buio per decenni. Si comincia a fare diagnosi e tentare le cure solo quando si manifesta, ma in quel momento è troppo tardi. Per questo gli sforzi che stiamo facendo sono per trovare un farmaco in grado, perlomeno, di rallentare la degenerazione. Negli Stati Uniti ne hanno licenziati due, uno lo scorso anno e uno in questo. Il primo è l'Aducanumab e il secondo Lecanumab, si tratta in entrambi i casi di anticorpi monoclonali, due farmaci che vanno a distruggere o a bloccare la produzione di placche di beta-amiloide. L'europa non li ha ancora approvati anche se sono certo che succederà presto per il secondo, che rispetto al primo ha un'efficacia modesta ed effetti collaterali importanti. Il Lecanumab invece, riesce a rallentare la malattia di circa un 30 per cento che è una percentuale importante se si pensa ad una persona di 80 anni che riesce a mantenere autonomia per altri 3 o 4 anni , evitanto l'impatto devastante della malattia su di lui e sulla famiglia".
Che tipo di farmaco è?
"Si tratta, come dicevo di un anticorpo monoclonale, che si somministra in ospedale per infusione, quindi per via endovenosa, e richiede controlli di risonanza ogni 2/3 mesi. Un farmaco impegnativo che però dimostra una certa efficacia. Ce ne sono anche altri in fase in fase tre di speramentazione perché, come spesso accade in medicina, la porticina che si è aperta lo scorso annocon il primo farmaco, ha aperto la strada ad altri, speriamo sempre migliori ed efficaci. È però importante sottolineare che tutti questi funzionano quando la diagnosi della malattia è precoce, ovvero ai primi accenni di sintomi. Su questo versante devo dire che il nostro Paese si è mosso per tempo, con un progetto che si chiama Interceptor,che si conclude quest'anno, finanziato dal ministero e da AIFA (Agenzia italiana del farmaco), di cui sono il coordinatore nazionale. Iniziato cinque anni fa, si è svolto su 500 soggetti con alto rischio di diventare pazienti con Alzheimer. Di questi sapevamo che solo la metà avrebbe sviluppato entro tre anni la patologia, per cui abbiamo abbiamo prelevato una serie di sostanze che si chiamano 'biomarcatori' e alla fine di quest'anno andremo a vedere quali di questi era già in grado di dirci chi si saebbe ammalato. Con questo strumento quando arriverà il farmaco, l'Italia sarà in grado di decidere miratamente a chi somministralo perché a rischio, e a chi no".
Si tratta di medicinali che curano i sintomi, o che riescono a bloccare la malattia?
"Sono in in grado di modificare l'andamento naturale della malattia e rallentarla. Quelli che noi stiamo usando ora, e che facciamo da vent' anni perché sono sempre gli stessi, servono invece solo per i sintomi, e non modificano l'esito della malattia. È come se qualcuno avesse la febbre e noi gli diamo solo l'aspirina che la abbassa, e non l'antibiotico che invece la cura, perché non ce l'abbiamo. Curiamo solo il sintomo ma la malattia continua a fare danni".
Si può considerare una scoperta rivoluzionaria nell'ambito di queste malattie?
"Con questi -che ancora non sono arrivati - e con altri che si stanno sperimentando, si può iniziare a ragionare con farmaci che sono in grado di rallentare o, in teoria anche bloccare, il peggioramento; ma voglio ancora sottolineare che vanno somministrati quando la malattia è molto agli inizi, se si va troppo avanti il danno è già eccessivo, e probabilmente ci sono altri meccanismi per cui, anche se si bloccano i beta-mieloidi, quella continua ad andare avanti".
Per altri tipi di malattie, come il tumore, c'è la possibilità di fare prevenzione, ma come si fa con le malattie neurodegenerative, visto che quando compaiono, come ha spiegato, è ormai tardi?
"In questo momento non c'è nè lo strumento, nè l'organizzazione per farlo.
Se, come dicevamo, ci sarà l'arrivo dei nuovi farmaci in grado di bloccare la malattia, è verosimile che si andrà in quella direzione, ovvero si cercherà di mettere a punto uno strumento, ed è quello che si sta sperimentando con lo studio di Interceptor, per fare uno screening di tutta la popolazione a rischio, ovvero le persone sopra i 55 anni e ancora di più per quelli che hanno una familiarità, in modo da procedere con la somministrazione precoce del farmaco".- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.


